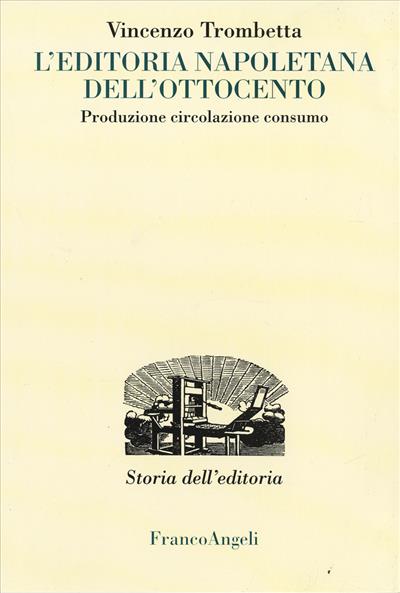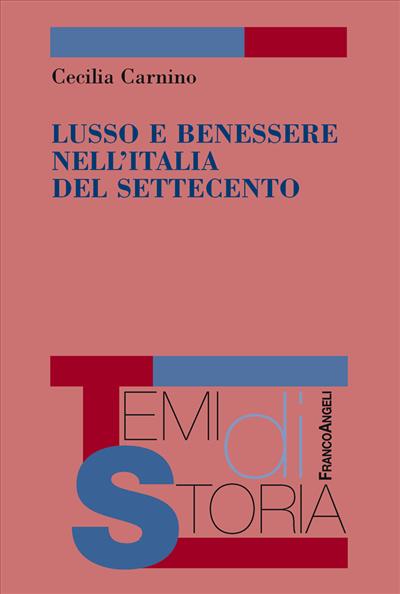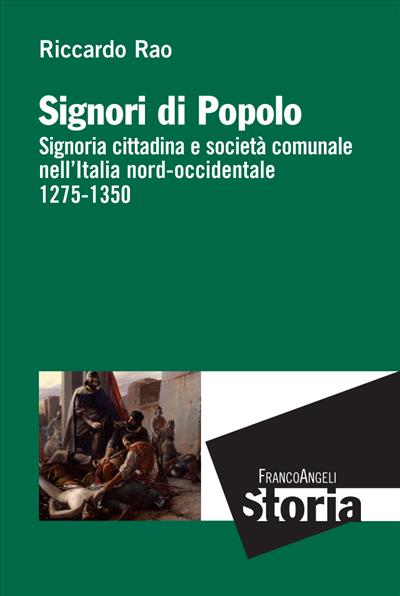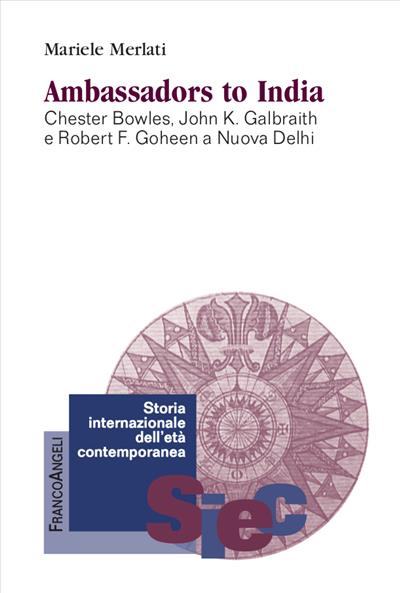A cura di: Franco Biasutti
Tramonto o metamorfosi dell'Umanesimo nell'età di Internet?
Edizione a stampa
26,50
Edizione a stampa
26,50
Pagine: 208
ISBN: 9788846444004
Edizione: 1a edizione 2003
Codice editore: 1406.4
Disponibilità: Discreta