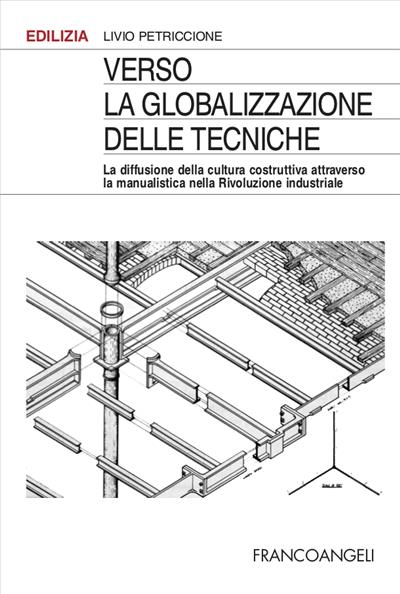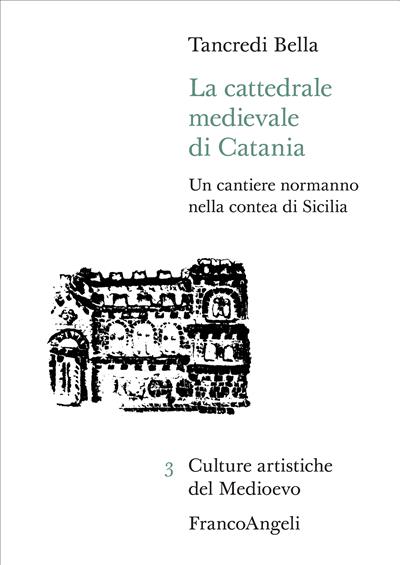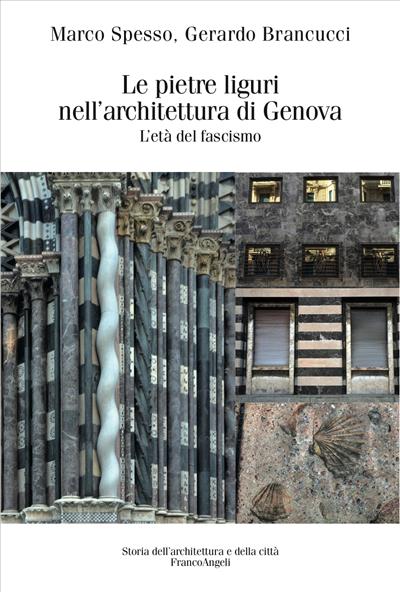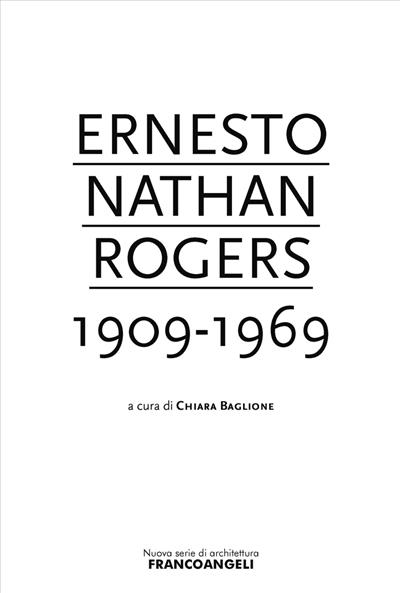Il surreale e l'architettura del Novecento
Edizione a stampa
21,50
Edizione a stampa
21,50
Pagine: 192
ISBN: 9788846453747
Edizione: 1a edizione 2004
Codice editore: 286.3.1
Disponibilità: Esaurito