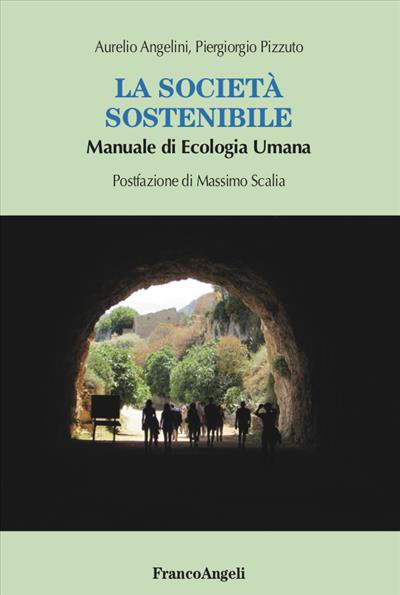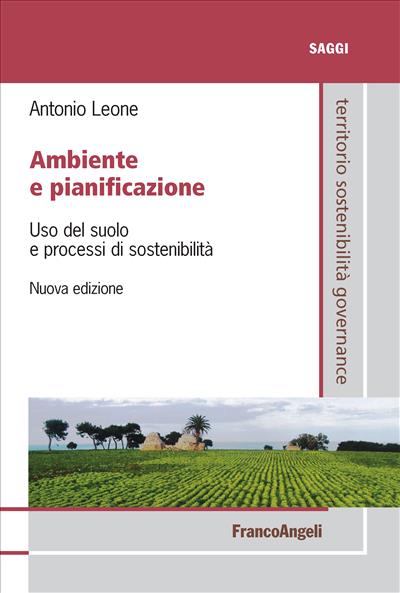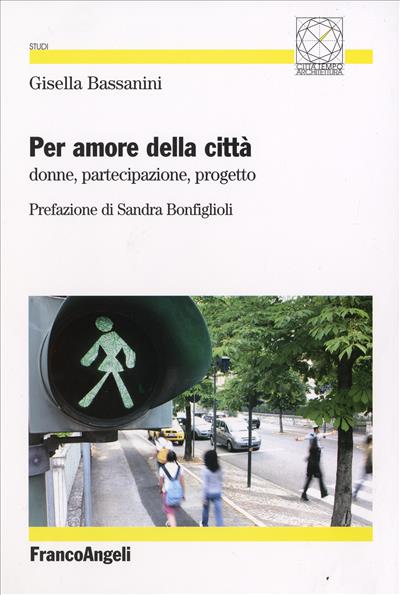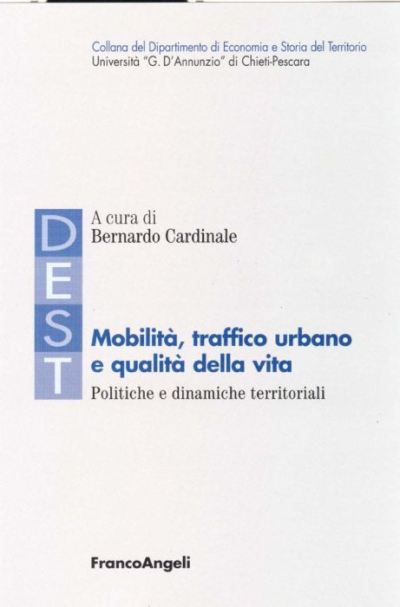
A cura di: Bernardo Cardinale
Mobilità, traffico urbano e qualità della vita.
Politiche e dinamiche territoriali
Edizione a stampa
34,50
Edizione a stampa
34,50
Pagine: 272
ISBN: 9788846457301
Edizione: 1a edizione 2004
Codice editore: 304.3
Disponibilità: Discreta