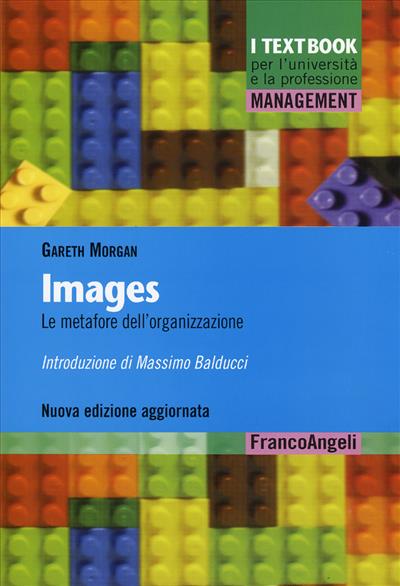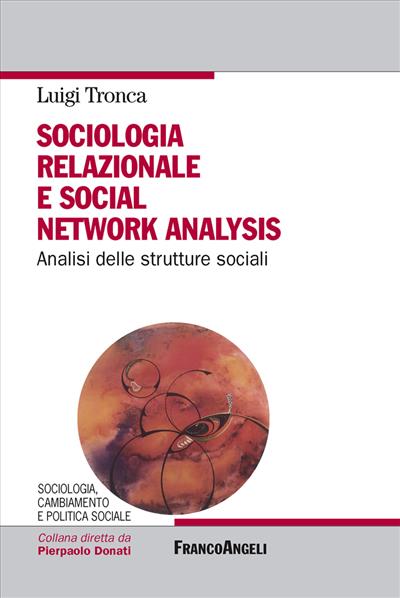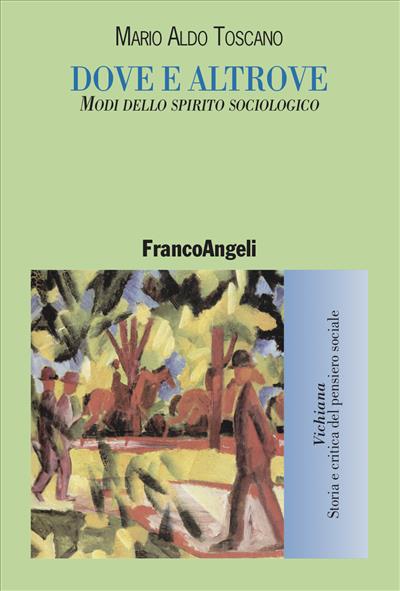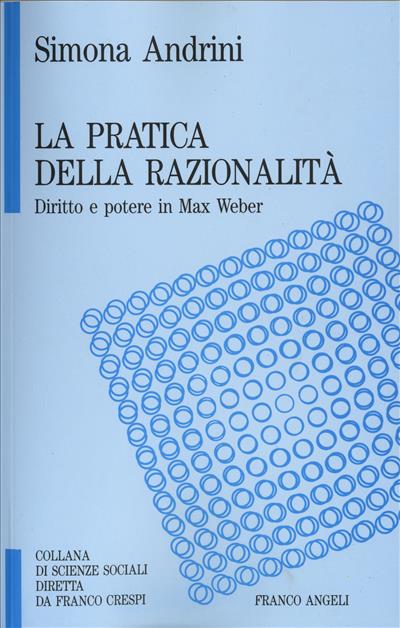
La pratica della razionalità
Diritto e potere in Max Weber
Edizione a stampa
16,50
Edizione a stampa
16,50
Pagine: 160
ISBN: 9788820466978
Edizione: 2a ristampa 2008, 2a edizione 2000
Codice editore: 233.4
Disponibilità: Nulla