Differenza, alterità e riconoscimento nell’agire sociale. Il caso di studio: "Donna: parliamone insieme"
Titolo Rivista EDUCATIONAL REFLECTIVE PRACTICES
Autori/Curatori Ada Manfreda
Anno di pubblicazione 2018 Fascicolo 2018/1
Lingua Italiano Numero pagine 21 P. 87-107 Dimensione file 268 KB
DOI 10.3280/ERP2018-001006
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più
clicca qui
Qui sotto puoi vedere in anteprima la prima pagina di questo articolo.
Se questo articolo ti interessa, lo puoi acquistare (e scaricare in formato pdf) seguendo le facili indicazioni per acquistare il download credit. Acquista Download Credits per scaricare questo Articolo in formato PDF
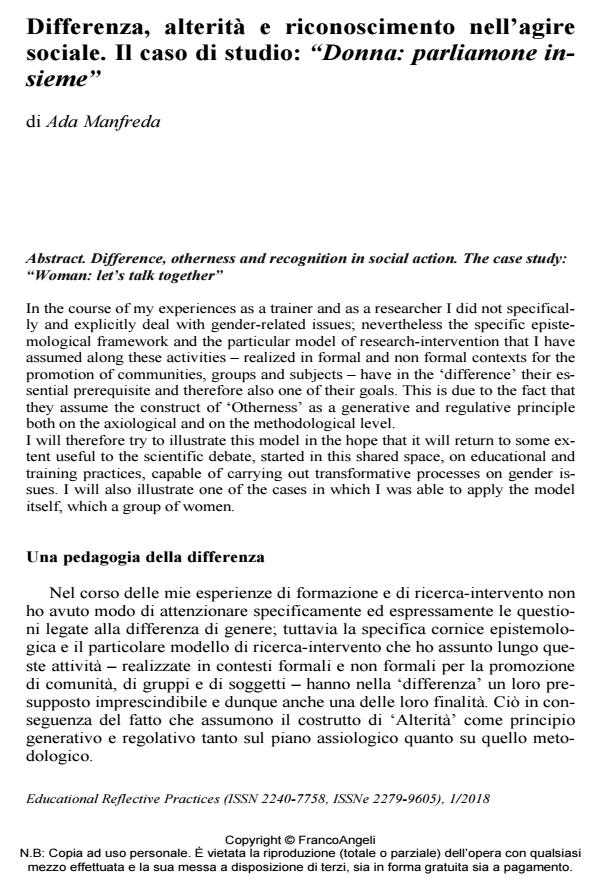
FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association, Inc (PILA)associazione indipendente e non profit per facilitare (attraverso i servizi tecnologici implementati da CrossRef.org) l’accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche
In the course of my experiences as a trainer and as a researcher I did not specifically and explicitly deal with gender-related issues; nevertheless the specific epistemological framework and the particular model of research-intervention that I have assumed along these activities - realized in formal and non formal contexts for the promotion of communities, groups and subjects - have in the ‘difference’ their essential prerequisite and therefore also one of their goals. This is due to the fact that they assume the construct of ‘Otherness’ as a generative and regulative principle both on the axiological and on the methodological level. I will therefore try to illustrate this model in the hope that it will return to some ex-tent useful to the scientific debate, started in this shared space, on educational and training practices, capable of carrying out transformative processes on gender is-sues. I will also illustrate one of the cases in which I was able to apply the model itself, which a group of women
- Becchi E. (1975). L’organizzazione della ricerca educativa. Firenze: La Nuova Italia.
- Boutinet J.P. (1990). Anthropologie du projet. Paris: Puf.
- Cambi F. (2011). Una stagione-chiave della “pedagogia critica”: il ’68 e dintorni. In: Colazzo S. (a cura di). Sapere pedagogico. Roma: Armando, pp. 58-71.
- Carli R., Paniccia R.M. (1999). Psicologia della formazione. Bologna: il Mulino.
- Carli R., Paniccia R.M. (2003). Analisi della domanda. Teoria e tecnica dell’intervento in psicologia clinica. Bologna: il Mulino.
- Colazzo S. (2011). La pedagogia alla luce del paradigma ecologico-sistemico. In: Bottaccioli F. (a cura di). Mutamenti nelle basi della scienza. L’emergere di nuovi paradigmi sistemici nelle scienze fisiche, della vita e umane. Milano: Tecniche Nuove.
- Colazzo S. (2013). Relazione, riconoscimento, empatia: una prospettiva pedagogico-sistemica. Riflessioni sistemiche, 8, luglio, pp. 78-86.
- Colazzo S., Manfreda A. (2014). La dimensione assiologica: significati e scopi. Alterità e Capacitazione. In: Ellerani P. (a cura di). Intercultura come progetto pedagogico. Lecce-Rovato: PensaMultimedia, p. 285, pp. 264-282.
- Demaria C., Sassatelli R. (2013). Visioni del femminile. Studi Culturali, X(3).
- Dewey J. (1984). Democrazia e educazione. Tr. it., Firenze: La Nuova Italia.
- Esposito R. (2002). Immunitas. Protezione e negazione della vita. Torino: Einaudi.
- Foerster (von) H. (1978). Sistemi che osservano. Trad. it. Roma: Astrolabio-Ubaldini.
- Freire P. (2004). La pedagogia dell’autonomia. Trad. it. Torino: Ega Editore.
- Goussot A. (2013). Dewey oggi: la pedagogia impossibile e l’utopia dell’educazione democratica. Educazione democratica. Rivista di pedagogia politica, 5: 15-46.
- Illich I. (2010). Descolarizzare la società. Tr. it., Milano: Mimesis.
- Jacob F. (1982). The Possible and the Actual. Seattle: University of Washington Press.
- Lancia F. (2004). Strumenti per l’analisi dei testi. Introduzione all’uso di T-Lab. Milano: FrancoAngeli.
- Lanzara G. F., Pardi F. (1980). L’interpretazione della complessità. Metodo sistemico e scienze sociali. Napoli: Guida.
- Ligorio M. B. (2004). Psicologia e culture. Contesti, identità, Interventi. Roma: Carlo Amore.
- Loiodice I. (2013). Inclusione sociale, Pedagogia oggi, 1: 209-219.
- Manfreda A. (2011). El mapeo de las necesidades como medio de mediación social. Zerbitzuan. Revista de servicios sociales, 50: 121-128, dicembre.
- Manfreda A. (2014a). La Mappatura dei Bisogni. Lettura semiotico-sistemico-regolatoria del soggetto e dell’agire sociale e definizione di un dispositivo di ricerca-intervento. Tesi di dottorato, Dipartimento di Storia, Società e studi sull’Uomo, Ciclo XXVI, Università del Salento, Lecce.
- Manfreda A. (2014b). La dimensione metodologica: mappatura dei bisogni per un intervento sociale capacitante. In: Binanti L. (a cura di). La capacitazione in prospettiva pedagogica. Lecce-Rovato: PensaMultimedia, p. 230, pp. 137-156.
- Montesarchio G., Venuleo C. (2009). Colloquio magistrale. La narrazione generativa. Milano: FrancoAngeli.
- Nussbaum M. (2012). Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL. Bologna: il Mulino.
- Peirce C. S. (2008). Alcune conseguenze di quattro incapacità. In: Peirce C. S., Scritti scelti. Torino: Utet, pp. 107-143.
- Petrilli S. (2001). Basi per una semiotica dell’io. In Sebeok Th.A., Petrilli S., Ponzio A. Semiotica dell’Io. Roma: Meltem, pp. 73-135.
- Petrilli S. (2003). Introduzione. In: Sebeok Th. A., Segni. Una introduzione alla semiotica. Roma: Carocci, pp. 11-44.
- Piaget J. (1967). Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia. Trad. it., Torino: Einaudi.
- Salvatore S., Guidi M. (2007). Note per un modello psicologico della competenza. Psicologia scolastica, 5(2): 197-231.
- Salvatore S. et alii (2010). La psicoterapia come scambio comunicativo. Prospettive di ricerca sul processo clinico. Ricerca in Psicoterapia/Research in Psychotherapy, 2(13): 241-286, -- http://www.researchinpsychotherapy.ne.
- Salvatore S., Venuleo C. (2013). Field and Dynamic Nature of Sensemaking. Theoretical and Methodological Implications. Papers on Social representations, 22: 21.1-21.41.
- Sebeok Th. A. (2001). L’io semiotico. In: Sebeok Th.A., Petrilli S., Ponzio A., Semiotica dell’Io. Roma: Meltemi, pp. 11-72.
- Sebeok Th. A. (2003). Segni. Una introduzione alla semiotica. Roma: Carocci.
- Striano M. (2007). Il dialogo come dispositivo formativo: incontro con Paulo Freire. Studi sulla formazione, X(1-2), Dossier monografico: Sulle orme di Morin: per una ‘pedagogia in grande’”. Bologna: Gedit, pp. 148-158.
- Tauber A. I. (1999). L’immunologia dell’io. Milano: McGraw-Hill.
- Le competenze di cittadinanza dei volontari del Servizio Civile Universale. Uno studio empirico Paolo Di Rienzo, Ada Manfreda, in Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal) 3/2022
DOI: 10.7358/ecps-2022-025-dima
Ada Manfreda, Differenza, alterità e riconoscimento nell’agire sociale. Il caso di studio: "Donna: parliamone insieme" in "EDUCATIONAL REFLECTIVE PRACTICES" 1/2018, pp 87-107, DOI: 10.3280/ERP2018-001006