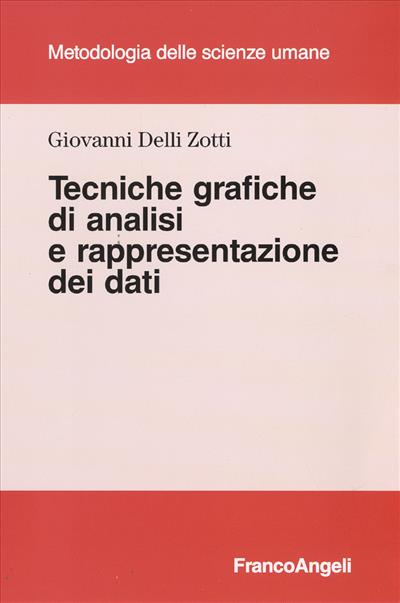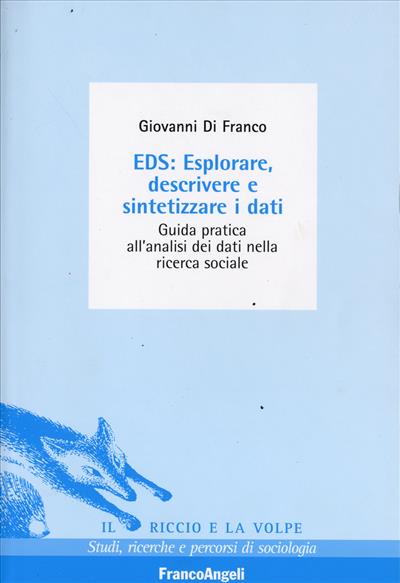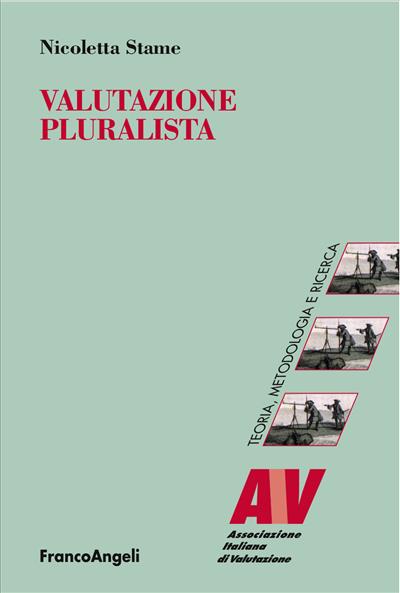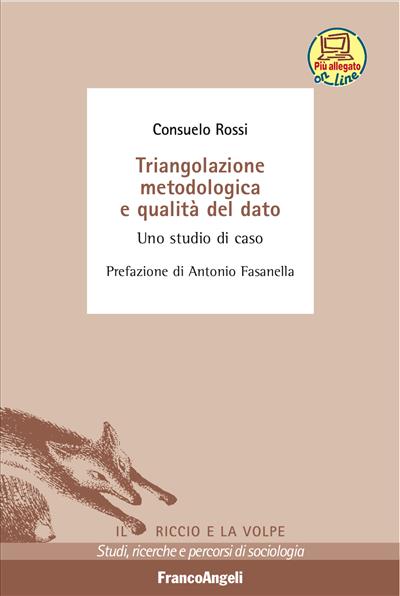
Triangolazione metodologica e qualità del dato.
Uno studio di caso
Con un approccio noto con l’espressione “triangolazione metodologica”, con la quale si indica la possibilità di studiare un fenomeno ricorrendo a più strumenti di indagine, una strategia ritenuta efficace in termini di progettazione e controllo della qualità del dato, il volume approfondisce il rapporto media-emergenze, analizzando l’impatto della rappresentazione televisiva del terremoto dell’Aquila.
Edizione a stampa
32,00
Edizione a stampa
32,00
Pagine: 304
ISBN: 9788891713759
Edizione: 1a edizione 2015
Codice editore: 1315.21
Disponibilità: Discreta
PDF con DRM
24,99
PDF con DRM
24,99
Pagine: 304
ISBN: 9788891732231
Edizione:1a edizione 2015
Codice editore: 1315.21
Possibilità di stampa: No
Possibilità di copia: No
Possibilità di annotazione: Sì
Formato: PDF con DRM per Digital Editions
EPUB con DRM
24,99
EPUB con DRM
24,99
Pagine: 304
ISBN: 9788891732248
Edizione:1a edizione 2015
Codice editore: 1315.21
Possibilità di stampa: No
Possibilità di copia: No
Possibilità di annotazione: Sì
Formato: ePub con DRM per Digital Editions