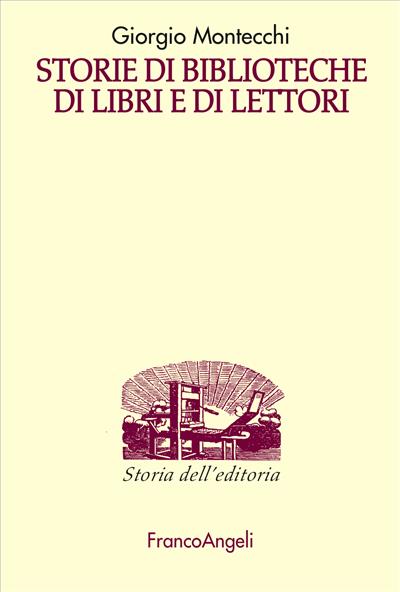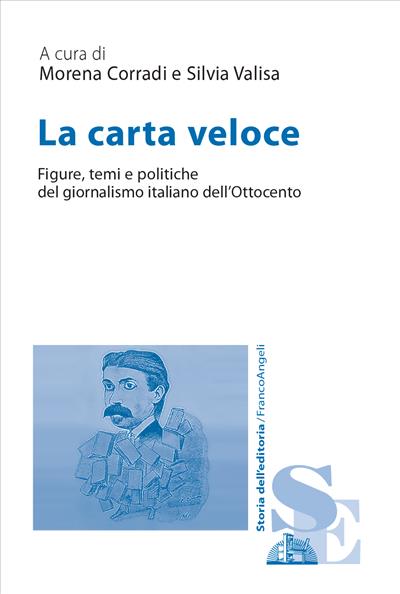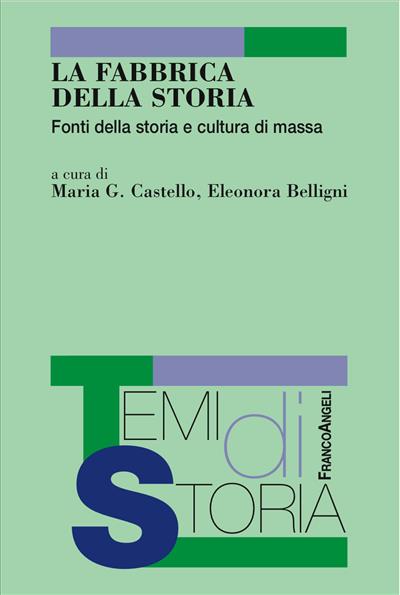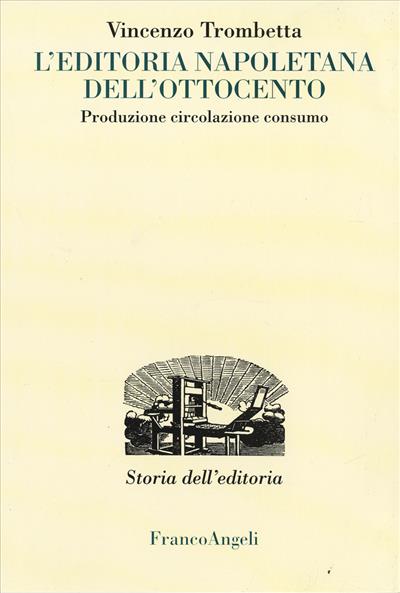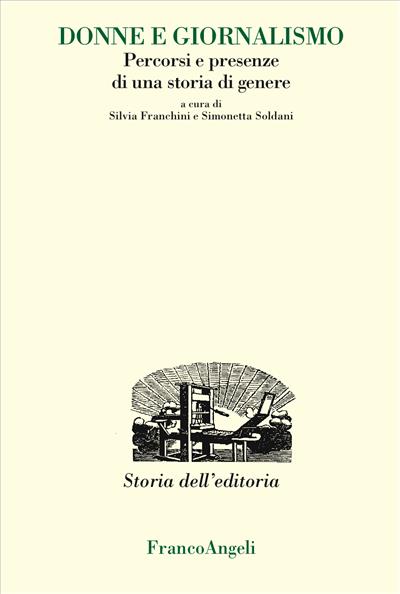
A cura di: Silvia Franchini, Simonetta Soldani
Donne e giornalismo
Percorsi e presenze di una storia di genere
Edizione a stampa
38,00
Edizione a stampa
38,00
Pagine: 400
ISBN: 9788846452894
Edizione: 5a ristampa 2022, 1a edizione 2004
Codice editore: 1615.23
Disponibilità: Discreta
PDF con DRM
32,00
PDF con DRM
32,00
Pagine: 400
ISBN: 9788891732750
Edizione:1a edizione 2004
Codice editore: 1615.23
Possibilità di stampa: No
Possibilità di copia: No
Possibilità di annotazione: Sì
Formato: PDF con DRM per Digital Editions