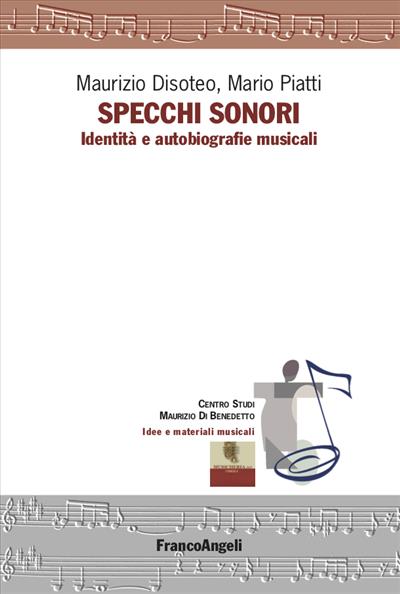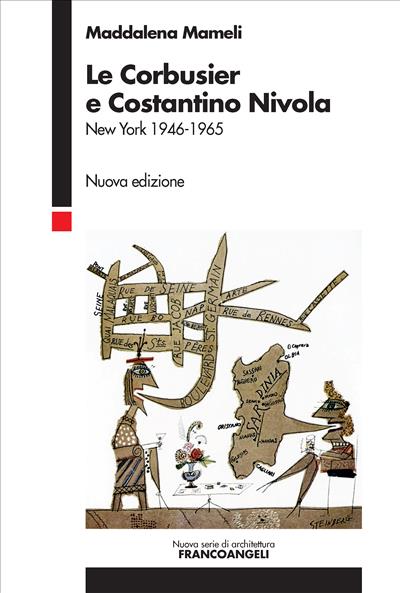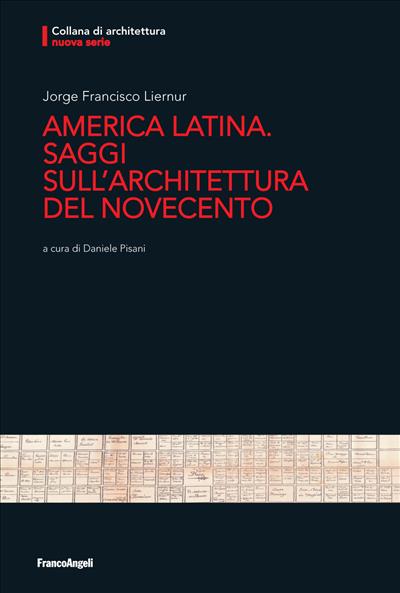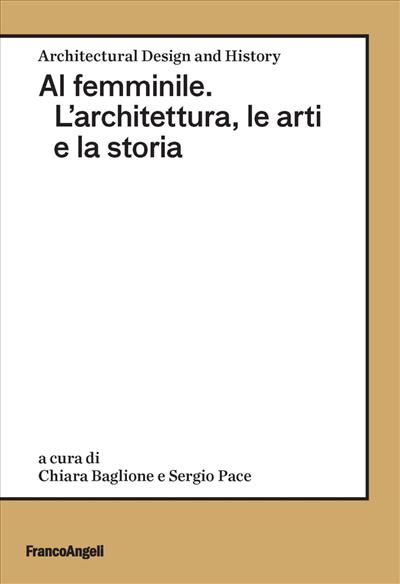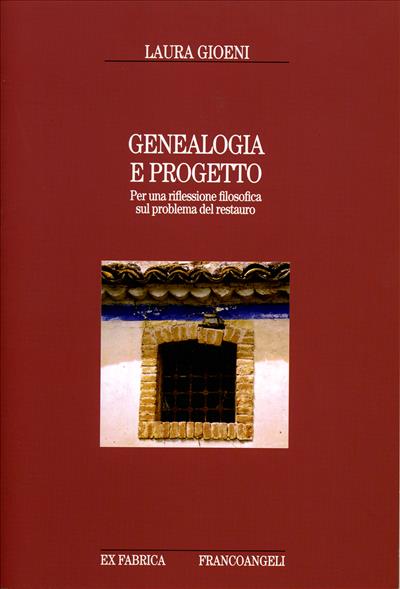
Genealogia e progetto.
Per una riflessione filosofica sul problema del restauro
Edizione a stampa
22,00
Edizione a stampa
22,00
Pagine: 160
ISBN: 9788846474452
Edizione: 1a edizione 2006
Codice editore: 491.1.3
Disponibilità: Esaurito