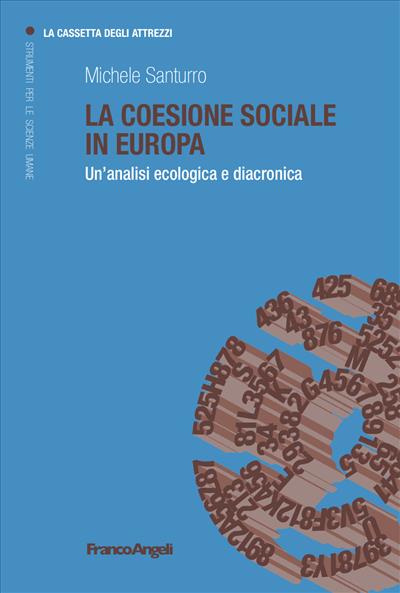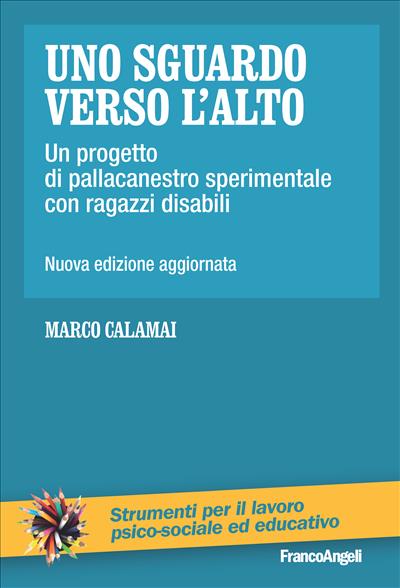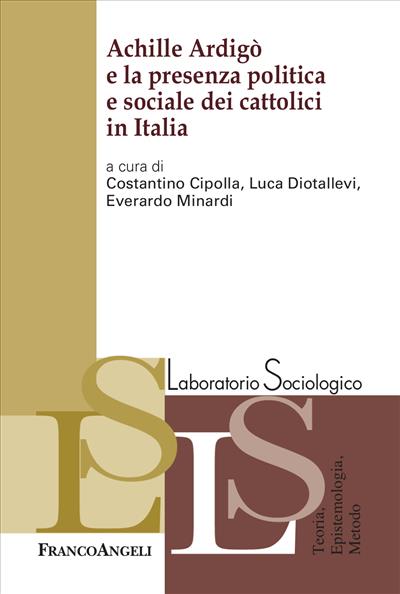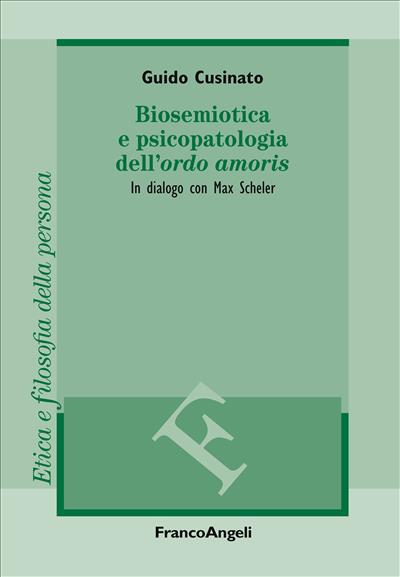A cura di: Michele Nicoletti
L'Empatia
Edizione a stampa
22,50
Edizione a stampa
22,50
Pagine: 208
ISBN: 9788820474768
Edizione: 2a ristampa 2006, 6a edizione 2002
Codice editore: 1140.16
Disponibilità: Esaurito